
HUMAN RELOAD - Outgrow your limits.
300 subscribers
About HUMAN RELOAD - Outgrow your limits.
“Pillole di Human Reload” https://amzn.eu/d/fJk3hnC Tutto il ricavato verrà donato alla LEGA DEL FILO D’ORO che da 60 anni supporta e aiuta i bambini sordociechi. Nel mondo di oggi le capacità umane evolvono più rapidamente dell'automazione. Gestiamo nuove tecnologie. Creiamo nuove sfide. Generiamo nuove opportunità. Il nostro obiettivo è riportare la centralità dell'uomo all'interno delle organizzazioni e della società, ripensando i processi attorno alle persone. Espandi il tuo potenziale oltre i tuoi limiti; solo focalizzandoti su nuovi obiettivi potrai raggiungere una nuova dimensione di soddisfazione professionale e personale. Riattiva te stesso. Riprogramma i tuoi limiti. [email protected] www.humanreload.com https://www.linkedin.com/in/felicevalente/
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

TUTTI VOGLIONO CAMBIARE, A PATTO CHE PRIMA CAMBI QUALCUN ALTRO. Cronache dalla trincea del cambiamento aziendale. Cambia tutto, purché nulla cambi. È il paradosso più elegante delle aziende: si parla di rivoluzione ma si agisce per restauro. Questa frase, apparentemente innocua, racchiude tutta l’ironia tragica delle trasformazioni aziendali moderne, dove il cambiamento si annuncia in power point e si nega nei comportamenti. Sembra la sceneggiatura non scritta di molte trasformazioni aziendali. Si annuncia il cambiamento come se fosse l’arrivo del Messia, si organizzano townhall, si preparano slide con titoli motivazionali, si ingaggiano consulenti dal curriculum lungo come la lista delle password dimenticate. Poi si gira l’angolo e… tutto è esattamente com’era. O quasi. Il badge è diventato digitale, la macchinetta del caffè ha il touch screen, ma il comportamento è lo stesso: riunioni inutili, decisioni rimandate, silenzi strategici e il solito “così si è sempre fatto”. Come quella volta in cui, dopo un’intera giornata di workshop sul decision making rapido, si è deciso di rimandare la scelta su una nuova piattaforma IT a ‘quando avremo più dati’, cioè mai. O quando si discute per settimane di empowerment e poi si aspetta il via libera del direttore anche per spostare una scrivania. Perché accade? Perché il cambiamento, quello vero, quello che tocca il modo di pensare e agire delle persone, trova sempre un avversario subdolo e invisibile: la resistenza. Non quella dei film storici con i partigiani, ma quella quotidiana, fatta di piccoli sabotaggi, esitazioni, incertezze mascherate da buon senso. Tutti dicono “Sì, vogliamo cambiare!”, ma dentro pensano: “Speriamo che non tocchi proprio a me”. Ogni organizzazione è una tribù, con le sue abitudini, i suoi riti, i suoi totem. Come il rito del lunedì mattina in cui ci si riunisce per un meeting in cui nessuno ha davvero qualcosa da dire, ma “si è sempre fatto così”. O il totem intoccabile della scrivania del fondatore, che anche se non c’è più da anni, resta lì come altare laico della cultura aziendale. E cambiare queste cose equivale, per molti, a una forma di morte simbolica. È come dire a qualcuno: da domani non sei più quello che pensavi di essere. E questo spaventa. Molto più di un taglio al budget o di un cambio di CEO. La mente umana non è progettata per l’incertezza. Di fronte all’ignoto, attiva il pilota automatico: si rifugia nell’esperienza, nell’abitudine, in ciò che conosce. Questo meccanismo è stato descritto da decine di modelli psicologici e organizzativi: da Kurt Lewin con la sua tripartizione “scongelare-cambiare-ricongelare”, dove ‘scongelare’ significa rompere le abitudini esistenti, ‘cambiare’ introdurre nuovi comportamenti e pratiche, e ‘ricongelare’ stabilizzare il nuovo assetto affinché diventi il nuovo normale, fino a John Kotter e le sue otto tappe della trasformazione. O l’ADKAR, che sembra il nome di un robot, ma è un acronimo che parla di consapevolezza, desiderio, conoscenza, abilità e rinforzo. Tutti strumenti utili, certo. Ma, come diceva un saggio collega: “I modelli sono come le mappe: servono per non perdersi, ma poi devi comunque camminare tu”. E qui casca l’asino: perché camminare, nel cambiamento, significa affrontare la paura. Prendiamo il caso di un’azienda che ha annunciato con grande enfasi la sua trasformazione agile. Nuovi ruoli, nuovi processi, stand-up meeting ogni mattina. Dopo sei mesi, lo scenario: i project manager continuano a comportarsi da capi progetto vecchia scuola, i team attendono indicazioni top-down e lo stand-up è diventato una riunione di status report travestita. Agile, ma solo nel nome. Oppure l’azienda che ha introdotto il lavoro ibrido, con l’obiettivo di favorire autonomia e responsabilizzazione. Risultato? I manager chiamano più spesso di prima per controllare se sei online. Il lavoro è diventato remoto, ma il controllo è rimasto presente. O ancora il caso di una fusione: due culture da integrare, due mondi che dovrebbero convergere. Sulla carta, missione compiuta. Nella realtà, due sistemi che si ignorano cordialmente. Gli ex A e gli ex B si parlano solo se costretti. Il cambiamento è stato dichiarato, ma non incarnato. La verità è che ogni cambiamento organizzativo passa da un cambiamento individuale. E ogni cambiamento individuale mette in crisi certezze, identità, comfort zone. Cambiare significa dire addio a una competenza che ci faceva sentire forti, a un ruolo che ci dava sicurezza, a una routine che ci faceva sentire “a casa”. E allora scatta la difesa. La resistenza non è cattiva volontà, è sopravvivenza emotiva. È l’impiegato che finge entusiasmo ma dentro pensa: “E se non sarò più all’altezza?”. È il manager che ostenta leadership ma teme: “Perderò il mio potere?”. È il team che sorride in plenaria ma in chat scrive: “Vediamo quanto dura stavolta”. Ecco perché ogni cambiamento dovrebbe essere prima di tutto un percorso di accompagnamento. Un cammino di consapevolezza, ascolto, confronto. Servono meno slogan e più dialoghi veri. Meno slide, più storie. Meno direttive, più domande. Serve aiutare ogni persona a riappropriarsi del proprio potere personale. In pratica, significa accompagnarla nel riconoscere di poter decidere, proporre, agire senza attendere istruzioni continue. Come ad esempio il middle manager che smette di chiedere conferme per ogni scelta operativa e inizia a guidare il team con iniziativa, oppure l’HR specialist che propone una nuova policy invece di aspettare che arrivi dall’alto. A capire che non è un ingranaggio da aggiornare, ma un protagonista da ingaggiare. Il passaggio è sottile ma fondamentale: da dipendente (che attende e subisce) a indipendente (che sceglie e agisce). Solo così il cambiamento smette di essere “qualcosa che ci piove addosso” e diventa “qualcosa che costruiamo insieme”. C’è però un rischio. Le aziende che riescono davvero a far crescere persone consapevoli, autonome, non allineate per default, devono poi fare i conti con un’organizzazione che non può più permettersi la mediocrità. Perché chi è risolto non obbedisce acriticamente. Chi ha vinto le sue paure non accetta più capi piccoli o obiettivi senza senso. Non sopporta più il capo che gestisce con micro-controllo e insicurezza, o i progetti lanciati solo per fare numero e senza impatto reale. Vuole interlocutori veri, senso nelle cose, direzioni che non cambiano con il vento delle mode manageriali. Chi ha preso possesso di sé pretende coerenza, visione, rispetto. E allora sì, il vero cambiamento fa paura. Ma non a chi lo subisce. A chi lo guida. Alla prossima pillola.


DAL MITO AL MOTIVATORE DI CORRIDOIO. Ovvero cronache semiserie di leadership aziendale in cerca di autore. C'è stato un tempo, neppure troppo lontano, in cui il leader era una figura mitologica. Un misto tra il comandante Achab e Superman, lì dove la visione si confondeva con la solitudine e il carisma fungeva da luce guida nei momenti di tempesta. Siamo nel dopoguerra, un'epoca in cui le aziende si ricostruiscono con lo stesso spirito con cui si ricostruiscono i ponti e le città: mattone su mattone, ordine dopo ordine, decisione dopo decisione. E il leader? È l'uomo solo al comando, con lo sguardo fisso sull'orizzonte e il peso del mondo sulle spalle. Pensiamo a Enrico Mattei, capace di sfidare l’ordine economico mondiale con una visione e un telefono. O a Enzo Ferrari, che più che un imprenditore sembrava un artista tragico, innamorato della velocità e della perfezione. Jack Welch negli anni ‘80 ne è stato l’epigono perfetto: duro, brillante, accentratore. In un contesto economico dominato dalla deregulation, dalla finanziarizzazione dell'impresa e da una crescente ossessione per la performance, Welch incarnava perfettamente l'immagine del CEO risolutore, capace di trasformare General Electric in una macchina da guerra competitiva. Era il simbolo di un'epoca in cui la leadership coincideva con la capacità di tagliare, accorpare, ottimizzare e ottenere risultati visibili in tempi rapidi. La leadership era verticale, direttiva, maschia (nel senso più iconico del termine), e si basava su una promessa: io vedo ciò che voi non vedete, seguitemi. Era un modello adatto a un mondo semplice (o che si faceva finta fosse tale). Il mercato si muoveva come un treno su binari: serviva qualcuno che guidasse la locomotiva e nessuno metteva in discussione la direzione, al massimo si commentava la velocità. Poi, come sempre accade nei romanzi più avvincenti, arrivò il colpo di scena: le crisi degli anni ’70. Il primo shock petrolifero del 1973 fu come un pugno nello stomaco al sistema industriale. Le certezze si frantumarono, i piani quinquennali divennero oggetti vintage. I leader scoprirono che la sola visione non bastava: bisognava anche saper navigare nella nebbia. La complessità richiedeva nuove lenti, nuovi strumenti. Fu in questo clima che nacque il modello della leadership situazionale di Hersey e Blanchard. Finalmente qualcuno ebbe il coraggio di dire che una sola maniera di guidare non basta. Il leader diventa qualcosa di più simile a un regista che a un generale. Deve saper leggere il contesto, adattarsi ai livelli di maturità del team, essere ora direttivo, ora partecipativo, ora coach, ora delegante. La leadership diventa fluida, relazionale, contestuale. Il leader inizia a scendere dal piedistallo per entrare nella stanza. Arrivano gli anni ‘80, con i completi doppiopetto, il walkman e una nuova parola che inizia a circolare nei corridoi delle business school: trasformazione. Bernard Bass introduce la leadership trasformazionale, contrapposta a quella transazionale. Non basta più scambiare salari per prestazioni. Ora il leader deve ispirare, coinvolgere, elevare. Mentre il modello transazionale si limita a dire: “Fai questo e avrai quello”, quello trasformazionale sussurra: “Diventiamo qualcosa di più, insieme”. La leadership inizia ad assumere tinte spirituali, nel senso di una dimensione valoriale più profonda: non si tratta solo di guidare un team verso un obiettivo, ma di connettersi con il senso di ciò che si fa, di ispirare una visione che tocchi motivazioni personali e collettive, quasi a sfiorare la sfera dell'identità e dello scopo. L'azienda diventa il luogo della realizzazione personale, il leader una sorta di guida carismatica che attiva il potenziale delle persone. Ecco che l'efficacia non è solo questione di risultati, ma anche di significato. In altre parole, l'efficacia sostenibile nasce dalla convergenza tra l'interesse dell'individuo e quello dell'organizzazione: quando le persone si sentono coinvolte, apprezzate e allineate con un senso più ampio, la loro motivazione aumenta. E con essa, guarda caso, anche la produttività e la redditività. È un po’ come un motore ben oliato: se ogni ingranaggio gira con piacere, la macchina non solo va, ma va anche lontano. Con l'arrivo degli anni 2000, qualcosa cambia in profondità. Le organizzazioni diventano più piatte, i progetti più incerti, il cliente più esigente. È l’epoca dell’Agile, del design thinking, dei post-it colorati appiccicati alle pareti delle sale riunioni. Il leader diventa un facilitatore, un coach, un architetto di contesti favorevoli. Nasce e si diffonde la Servant Leadership: una leadership che non comanda, ma serve. Che non brilla da sola, ma accende gli altri. Come un motivatore di corridoio che non forza la crescita, ma sa quando offrire un post-it, un feedback o un caffè strategico al momento giusto. Amazon, ad esempio, nel suo famoso Leadership Principles include esplicitamente concetti come "Earn trust" e "Hire and develop the best". Anche Salesforce ha reso centrale la leadership a servizio nei suoi modelli organizzativi, valorizzando l'ascolto e l'empowerment dei team come leve strategiche. Queste aziende dimostrano come mettere le persone al centro non sia solo un vezzo retorico, ma un vantaggio competitivo concreto. Lì dove una volta si cercava l'eroe, oggi si cerca l'enabler. Non è più tempo di salvatori, ma di moltiplicatori. Oggi, nel mezzo del caos digitale, delle Generazioni Z e delle Great Resignation, la leadership è diventata una danza. Non più un passo solo, sempre uguale, ma una continua improvvisazione. Serve ascolto, empatia, lucidità strategica, capacità di stare nella contraddizione. E proprio da qui nasce la sfida più grande per le aziende: non tanto avere leader brillanti, ma creare ecosistemi in cui la leadership diffusa sia possibile. Dove ogni collaboratore possa sentirsi parte della costruzione del valore. Oggi, chi cerca lavoro o vuole restare in azienda non cerca più solo la busta paga o la scrivania vista open space. Cerca senso, coerenza, relazioni autentiche. E la leadership? Non è più un talento riservato a pochi eletti o un'aura che discende dall'alto. È un agito quotidiano, distribuito, condiviso. È un modo di essere, prima ancora che un ruolo. La vera svolta sta nel riconoscere che tutti, in un team, possono esercitare leadership. Non si tratta più di "avere il capo giusto", ma di essere immersi in un contesto che attiva la responsabilità diffusa. Se ben progettata, l'organizzazione non genera solo efficienza, ma consapevolezza. E con essa, capacità di guida, presa di iniziativa, orientamento al miglioramento. In un mondo di vetrine patinate, l'onestà è il nuovo sexy. Come quei ristoranti che ti dicono: “Serviamo solo quattro piatti, ma sono fatti con amore". Le aziende che dichiarano apertamente che la leadership non è un superpotere ma una pratica collettiva, imperfetta ma sincera, diventano nuove calamite per i talenti. Non serve più il leader con la bacchetta magica, ma un ecosistema che aiuti ognuno a trovare la propria voce e il proprio coraggio. E in fondo, la leadership oggi è proprio questo: non dire agli altri dove andare, ma creare le condizioni perché ciascuno trovi la propria direzione. Anche a costo di ammettere che, ogni tanto, ci si perde. Ma insieme.


*CRESCIAMO INSIEME.* Vorrei esprimere un ringraziamento speciale a tutti coloro che in questi primi mesi del 2025 hanno acquistato il libro “Un Anno Insieme” PILLOLE DI HUMAN RELOAD, contribuendo in questo modo ad aiutare gli operatori e i volontari dei centri della *Lega del Filo D’Oro.* *Oltre cento copie* sono state acquistate in questi pochi mesi: questo è un risultato davvero incredibile e per noi un prezioso riconoscimento per il lavoro svolto. *Grazie davvero di cuore a tutti quelli che credono in questo progetto.*❤️ Speriamo che la lettura sia stata leggera, gradevole e coinvolgente. Vi chiederei qualche istante del vostro prezioso tempo per commentare/recensire il libro sulla piattaforma Amazon a questo indirizzo https://amzn.eu/d/6zNNPhh Questo vostro piccolo contributo rappresenta per noi un dono di enorme valore. A coloro che invece non ne hanno acquistata una copia dico…cosa state aspettando 😊? Fate presto 🏃🏻♂️🏅 Un libro, un regalo, un passatempo, una sfiziosità manageriale. Ma soprattutto una *buona azione*. PILLOLE DI HUMAN RELOAD: Un anno insieme. Oltre 60 pillole di freschezza e riflessioni sul mondo del lavoro attuale, in una forma di diario settimanale volto a farvi compagnia nelle nostre giornate lavorative. *GRAZIE!*


L’EVOLUZIONE (PRESUNTA) DELLA SPECIE HR. Da “reparto timbri, paghe e contributi” a stratega della sostenibilità. Se l’azienda fosse una nave, la funzione HR non sarebbe il mozzo che registra le presenze dei marinai, ma il navigatore che suggerisce la rotta. E quando la destinazione si chiama sostenibilità, non basta saper galleggiare: serve una mappa, una visione e il coraggio di cambiare direzione. Per troppo tempo le Risorse Umane sono state viste come il reparto dei timbri e delle buste paga. Ma oggi, in un mondo che cambia alla velocità della luce, tra pressioni competitive, urgenze climatiche e tensioni sociali, l’HR deve smettere i panni dell’impiegato amministrativo e indossare quelli del cambiatore seriale. Il cambiamento sostenibile non è fatto di slide ESG o di comunicati stampa green: nasce da decisioni quotidiane, da coerenza culturale e da persone consapevoli. Negli ultimi anni, acronimi come ESG – Environmental, Social, Governance – sono diventati ovunque: nei meeting, nelle newsletter, sulle spillette. Eppure, proprio in questo proliferare di buone intenzioni, il rischio più grande è che la sostenibilità diventi un'altra moda da catalogo. Ma chi, se non l’HR, può trasformare quelle tre lettere in pratiche organizzative? Chi può fare in modo che ESG non sia un'etichetta ma un comportamento? Parliamo allora di azione concreta. L'Environmental è anche reclutare talenti sensibili ai temi ambientali, favorire pratiche ecologiche sul luogo di lavoro, progettare modelli ibridi che riducano l'impatto ambientale. Il Social è promuovere inclusione, sicurezza psicologica, equità, dialogo. E la Governance è cultura organizzativa, trasparenza e responsabilità. Se non se ne occupa l’HR, lo farà davvero qualcun altro? Viviamo peraltro in un paradosso: proprio mentre il mondo dovrebbe accelerare, assistiamo a un ripensamento delle strategie ESG in alcuni grandi gruppi. BlackRock riformula, ExxonMobil rallenta. E intanto la polarizzazione politica e la pressione degli azionisti più tradizionali mettono in pausa molti slanci. Ma è proprio adesso che l’HR deve tenere viva la fiamma. Perché la sostenibilità non è una strategia: è una visione del mondo, fatta di micro-decisioni che modellano il modo in cui lavoriamo, guidiamo e collaboriamo. Come farlo? Inserendo indicatori ESG nei sistemi di performance. Facendo del benessere organizzativo una voce nei board meeting. Formando manager a gestire dilemmi etici, non solo KPI. In breve: spostando il baricentro da “facciamo vedere che siamo sostenibili” a “diventiamo sostenibili, davvero”. E non è solo teoria. Patagonia, per esempio, ha integrato la sostenibilità nella propria cultura HR, con flessibilità, supporto alla genitorialità e coinvolgimento attivo dei dipendenti. Unilever lega gli obiettivi ESG alla retribuzione dei manager: se vuoi il bonus, non basta vendere di più. Enel investe nella formazione su questi temi, non come corso obbligatorio, ma come leva strategica. IKEA lavora da anni sull’equilibrio di genere e sull’ascolto interno come strumenti di trasformazione. Tutto questo ci porta al cuore del tema: la relazione tra HR, CEO e Board. Troppo spesso sembrano tre condomini che condividono l’ascensore ma non si salutano. Eppure, è ora di riscrivere questo triangolo. L’HR deve essere coinvolto nei processi strategici fin dall’inizio. Il CEO deve smettere di considerarlo un reparto di supporto e iniziare a vederlo come co-pilota del cambiamento. Il Board deve comprendere che la cultura, il benessere e l’inclusione non sono fronzoli, ma asset competitivi. Abbiamo bisogno di passare dal poster alla pratica. Quelle attività HR che una volta venivano considerate “nice to have” – come la DEI, le survey sul clima, i percorsi di ascolto – oggi fanno davvero la differenza. Perché le nuove generazioni scelgono dove lavorare in base a valori. Gli investitori guardano agli ESG per valutare i rischi. E i clienti premiano le aziende che trattano bene le persone, dentro e fuori. Per concludere: se l’organizzazione è una squadra di calcio, l’HR non è il massaggiatore che entra in campo quando qualcuno si fa male. È il direttore sportivo che seleziona il talento, costruisce lo spogliatoio e definisce il gioco con l’allenatore. Oppure, se preferite il cinema, non è il tecnico delle luci: è il produttore esecutivo che tiene insieme cast, copione e pubblico. E quando il film parla di sostenibilità, inclusione e impatto, serve che sia un blockbuster. Non un cortometraggio da festival di nicchia. La funzione HR è oggi l’unico vero connettore sistemico tra strategia, cultura, persone e impatto ESG. Ma per giocare davvero questo ruolo, deve alzare la voce, entrare nel cuore delle decisioni, sfidare lo status quo. Serve una nuova alleanza con CEO e Board: non più solo esecutori, ma co-architetti del futuro. Perché se vogliamo un mondo più sostenibile, equo e prospero, dobbiamo iniziare da chi ha il potere – e il dovere – di progettare organizzazioni più umane. E se non lo fa l’HR… allora chi? I cambiamenti culturali non si implementano. Si incarnano!


INTRAIMPRENDITORIALITÀ: ovvero quando il dipendente diventa (quasi) imprenditore. Una narrazione pungente, affettuosa e molto concreta su come trasformare la routine aziendale in una fucina di iniziativa interna. C'è una credenza diffusa, dura a morire, secondo cui il "buon" dipendente è colui che segue la linea, un'idea che affonda le sue radici nel modello organizzativo fordista e taylorista, dove efficienza e ripetibilità prevalevano sull'iniziativa personale, sta nel perimetro del suo ruolo e si limita a migliorare l'esecuzione. Ma oggi, in un mondo dove le slide strategiche invecchiano prima dei pomodori, serve un altro tipo di energia: quella dell'intraimprenditore. Non parliamo di eroi solitari, ma di persone che, pur rimanendo dentro le organizzazioni, sviluppano e fanno crescere idee nuove. In altre parole: hanno più progetti, ma non sono multitasker. Sono esploratori autorizzati. Molti manager ancora confondono l'intraimprenditorialità con il multitasking. "Stai già seguendo due cantieri, figurati se ti autorizzo a partire con un terzo progetto!". Peccato che quei progetti laterali non siano dispersione, ma fertilizzazione incrociata. Lavorare su più fronti permette di generare soluzioni fuori dallo schema del ruolo, evitare la noia (il vero costo nascosto), allenare la capacità di leggere segnali deboli. L'intraimprenditorialità non è caos. È un modo per trasformare un team di esecutori in una rete viva di persone, come suggerisce la teoria delle organizzazioni fluide e dei network adattivi, che valorizza la collaborazione distribuita e l'interconnessione dinamica tra individui che, insieme, costruiscono futuro. L'intraimprenditore è curioso come un bambino con le mani nei LEGO. Non si accontenta del "si è sempre fatto così". Non ha bisogno del timbro, ma apprezza un feedback vero. Ha coraggio, ma non incoscienza. È mosso da senso di impatto, non da carriera. Soprattutto, ha bisogno di un ambiente che non gli chieda continuamente "dove sei arrivato?", ma piuttosto: "cosa hai imparato finora?" Quando non funziona, i motivi sono spesso ricorrenti. Il primo è il paradosso della libertà apparente: si dichiara apertura, ma poi tutto deve passare da comitati e approvazioni. Il secondo è l'effetto hobby: si trattano i progetti laterali come "passatempi". Così li si svuota di valore. Il terzo è l'invidia funzionale: alcuni ruoli godono di più libertà innovativa di altri. Risultato? Malumori e passività. Molte imprese si raccontano ancora come se fossero templi della coerenza: mission, vision, valori, purpose. Poi basta parlare dieci minuti con un dipendente per scoprire che la realtà è più complessa. Non necessariamente peggiore, solo più umana. Ed è qui che si apre la sfida: oggi i talenti non cercano aziende perfette, ma aziende vere. Che dichiarano le loro contraddizioni. Che ammettono che stanno imparando. Che condividono anche le versioni beta di sé stesse. Un'organizzazione che coltiva intraimprenditorialità diventa un ecosistema, secondo l'approccio sistemico ed ecologico delle organizzazioni, e non più un impianto a circuito chiuso. È aperta all'imprevisto, alla proposta inattesa, all'energia che arriva dai suoi stessi corridoi. E soprattutto, diventa credibile. Perché la credibilità oggi non si gioca sulla coerenza impeccabile, ma sull'onestà narrativa: mostrare i piani, ma anche i ripensamenti. Condividere le priorità, ma anche le difficoltà. Dare spazio alle persone, non solo ai processi. In sintesi? Le aziende che sopravviveranno non saranno le più strutturate, ma quelle capaci di esprimere una resilienza organizzativa autentica, fondata su capacità di adattamento continuo, secondo i modelli di apprendimento dinamico e complessità sistemica, ma quelle che sanno reinventarsi grazie alla loro linfa più preziosa: le persone che osano anche dove non è (ancora) previsto.


TRANQUILLO, AL MEETING PARLO IO (tanto so già cosa vuoi dire). Nel complesso ecosistema delle aziende moderne, dove ognuno interpreta il proprio ruolo tra piani strategici, performance review e riunioni che sembrano talk show infiniti, si aggira una figura relazionale spesso trascurata ma molto presente: il capo overcaring. È quel leader che, con un eccesso di premura, finisce per dimenticare che il collaboratore è un adulto capace di pensiero autonomo. Questo testo è per loro. E per chi ci finisce sotto. Ci hanno insegnato che un buon capo si prende cura del proprio team. Che ascolta, supporta, guida. Ma dove sta il confine tra cura e controllo, tra supporto e sostituzione? Quando il capo, invece di creare lo spazio per la crescita del collaboratore, lo invade con la dolcezza di una nonna col maglione di lana in agosto, qualcosa si incrina. Frasi come: "Secondo me dovresti accettare quel progetto, fa bene alla tua carriera", oppure "Io, al posto tuo, parlerei subito con il cliente così", o ancora "Dai, ti ho già prenotato il corso, poi mi ringrazierai", suonano premurose, ma nascondono un sottotesto preciso: non mi fido che tu sappia decidere da solo. Il collaboratore, lusingato, entra in un vortice di dipendenza. Perché di fronte all'incertezza, l'essere umano tende a cercare figure protettive. Ma attenzione: il confine tra "protettivo" e "manipolativo" è sottile come la linea che separa la coccola dal soffocamento. Quando il capo si comporta come un genitore ansioso, il collaboratore smette di crescere. Entra nella parte del figlio che non può disobbedire, perché ogni scelta è già stata anticipata, confezionata, magari pure impacchettata con un bel fiocco motivazionale. E così il capo pensa per due. Decide per due. Vive per due. Convinto di esercitare la leadership. Ma quella non è leadership, è puppeting. Un esempio lampante lo troviamo in un caso aziendale citato in un articolo di Harvard Business Review del 2022: in una giovane azienda tech americana in rapida crescita, con una cultura ancora in costruzione e forte pressione sugli obiettivi, un manager di medio livello, nel tentativo di "aiutare" i propri collaboratori più giovani, finiva per dare loro istruzioni precise su come parlare durante i meeting, cosa scrivere nelle mail, quando proporre idee. I collaboratori, inizialmente grati per la guida rassicurante in un ambiente competitivo, si ritrovarono in breve tempo incapaci di agire senza l'approvazione del capo. Il risultato? Un team brillante trasformato in una compagnia di marionette silenziose. Il paradosso è evidente: il capo overcaring si illude di costruire fiducia, ma finisce per minarla. Perché nel momento in cui anticipi ogni decisione del collaboratore, gli stai dicendo che da solo non ce la può fare. E lui, magari inconsciamente, ti crede. Con il tempo, succedono due cose: il collaboratore smette di assumersi rischi, tanto "ci pensa il capo"; il capo si convince di essere indispensabile: l'eroe della situazione. Si crea così una relazione tossica, ma socialmente accettata. Anzi, in molte aziende è pure premiata: il capo viene celebrato per la sua "dedizione", il collaboratore per la sua "fedeltà". E via, un altro premio di team dell'anno. Un buon coach non ti dice cosa fare. Ti fa domande, ti allena a pensare. Ti accompagna nell'incertezza, senza rubarti il volante. Ma il capo-overcaring non ha sviluppato questa capacità. E così, guidato da buone intenzioni (ma anche da un ego ben nutrito), confonde il coaching con il suggerimento travestito da consiglio. "Io farei così" è spesso un modo gentile per dire: "se non lo fai, stai sbagliando in partenza". In una grande azienda europea, un direttore HR raccontava: "Nel nostro team avevamo un manager bravissimo tecnicamente, ma ogni volta che un collaboratore portava un'idea, lui la smontava dicendo 'guarda, meglio se fai così'. Dopo sei mesi, nessuno proponeva più nulla. E lui si chiedeva perché il team non fosse più proattivo." Non sempre il collaboratore resta nella sua zona di comfort generata dall'overcaring. A volte si accorge che qualcosa non torna. Che la sua voce interiore si è abbassata. Che il senso di autonomia è evaporato. E allora, succede la rivoluzione. "Sai che c'è? Grazie dei consigli, ma questa volta voglio provare da solo." In quel momento il capo ha due scelte: sentirsi tradito e riprendersi la palla, o accettare che il proprio ruolo non è fare il gol, ma costruire il campo da gioco. Immagina di essere su un'auto. Il collaboratore guida. Il capo è il navigatore. Ma invece di suggerire strade, il navigatore comincia a frenare, sterzare, accendere le frecce. Alla fine, chi guida? L'overcaring è questo: una disfunzione del ruolo, mascherata da zelo. Ma non è la presenza a rendere sicuri. È la fiducia. Il mondo del lavoro non ha bisogno di capi-mamma o collaboratori-yes man. Ha bisogno di adulti che si confrontano, si ascoltano, si sfidano. Serve una nuova grammatica della relazione capo-collaboratore, dove il capo è allenatore, non regista, il collaboratore è co-protagonista, non esecutore, entrambi si allenano a domandare, più che a consigliare. Una relazione fluida, dove si cresce insieme. Dove ogni "secondo me dovresti" lascia spazio a un "cosa ti sta a cuore?". Dove il successo non è far fare le cose agli altri, ma vederli fiorire nella loro autonomia. In fondo, un buon capo non è quello che ti protegge da tutto. È quello che ti allena a camminare, anche quando la strada trema. E se ogni tanto sbagli, pazienza. Vuol dire che stai decidendo tu. Ecco perché è fondamentale che le aziende inizino a premiare chi sa far crescere le persone, non chi le controlla con dolcezza. Perché la vera leadership non si misura nella quantità di decisioni prese al posto degli altri, ma nella capacità di far emergere il potenziale altrui.


COERENZA CERCASI, ANCHE USATA. Nel mondo di oggi, comunicare chi sei come azienda è un po’ come cercare di fare un selfie su un treno in corsa: lo scatto viene sempre mosso, sfocato o con un riflesso indesiderato. L’Employer branding non è solo una pagina patinata su LinkedIn, è una promessa in diretta 24 ore su 24. E le persone – i dipendenti, i candidati, i clienti, i follower – quella promessa la confrontano con i dettagli: il modo in cui rispondi alle mail, come accogli un nuovo collega, cosa succede quando nessuno guarda. Viviamo in una bolla comunicativa costante, e ogni cosa che l’azienda dice (o non dice) può essere usata contro di lei… o a suo favore. Le aziende si trovano oggi su un crinale instabile: da una parte c’è la volontà di mostrarsi moderne, inclusive, sostenibili, agili, digitali. Dall’altra, c’è la dura realtà dei processi lenti, dei silenzi imbarazzanti, dei manager che non hanno ancora capito cosa significhi ascoltare. La coerenza è l’arte del funambolo in scarpe antinfortunistiche: vorresti danzare leggero, ma pesi come una cultura aziendale costruita in anni di «abbiamo sempre fatto così». In un contesto costantemente incerto, volatile e ambiguo, mantenere una narrativa aziendale lineare è impresa da eroi. Le aziende cambiano strategia ogni trimestre, ma il loro tono di voce resta spesso ancorato agli anni ’90. Il risultato? Un disallineamento semantico che si percepisce anche al microonde dell’open space. La schizofrenia comunicativa è uno sport aziendale diffuso. All’esterno, campagne da urlo: video motivazionali con musica epica, slogan sulla centralità della persona, storytelling emozionale degno di Pixar. All’interno, moduli Excel da compilare, feedback non richiesti e aggiornamenti sulle ferie via PowerPoint. Come si può costruire un employer branding credibile se l’ecosistema interno e quello esterno non si parlano? È come aprire un ristorante stellato con la cucina a vista… e poi cucinare in una mensa scolastica. Il disincanto è inevitabile. Caso emblematico? Amazon. All’esterno, Amazon è un colosso dell’innovazione, del customer obsession, della logistica impeccabile. All’interno, i racconti di alcuni ex magazzinieri su condizioni di lavoro discutibili e algoritmi che ti licenziano con un click creano uno scollamento difficile da ignorare. L'employer branding qui si basa sull’efficienza, ma rischia di trasformarsi in un boomerang se non c’è cura autentica per chi tiene in piedi quella macchina. Cosa possono fare le aziende sane (senza farsi venire l’orticaria) - Raccontare l’imperfezione: dire “non siamo perfetti, ma ci lavoriamo” è molto più potente del millantare eccellenze ovunque. - Coinvolgere le persone vere: basta testimonial finti. I dipendenti reali raccontano meglio, anche con tutte le loro esitazioni. - Misurare la coerenza: creare indicatori che confrontano quanto comunicato con quanto realmente percepito. - Favorire il dissenso costruttivo: creare canali dove le persone possano esprimersi senza timore di ritorsioni. - Rivisitare il tono di voce: non serve essere brillanti, ma autentici. Meglio un tono umano che una frase da spot. Il rapporto tra azienda e persona (dipendente o candidato) non è più basato su aspettative unilaterali. È una relazione, fatta di fiducia, ascolto, limiti e contraddizioni. Il nuovo employer branding non è una campagna, è una conversazione continua. E in quella conversazione, l’azienda non deve per forza avere sempre ragione. In un mondo instabile, l’unica coerenza sostenibile è quella che include l’evoluzione. Le aziende devono iniziare a dire: "Siamo cambiati, ecco perché". Ammettere l’incoerenza temporanea è un atto di maturità. Rende più credibili, non meno. Cosa mettere in pratica domani quindi? Le aziende potrebbero iniziare aprendo la comunicazione interna anche agli occhi esterni, rendendo accessibile il magazine aziendale ai candidati in cerca di un segnale autentico. Una buona abitudine sarebbe quella di creare un vero e proprio "diario di bordo" aziendale: una sintesi trimestrale dei cambiamenti avvenuti, con le relative motivazioni. Un altro passo utile sarebbe introdurre la figura del "custode della coerenza", un ruolo trasversale incaricato di monitorare e allineare il racconto aziendale. E, infine, forse la cosa più rivoluzionaria di tutte: smettere di celebrarsi a ogni occasione e iniziare, più semplicemente, a spiegarsi. La verità aziendale è come una scrivania il venerdì pomeriggio: disordinata, stanca, segnata da post-it caduti, appunti a penna sbiaditi, tazze sporche e fogli dimenticati sotto le tastiere. Ma se ci guardi bene, contiene le tracce di ciò che sei davvero: i dettagli non filtrati, i gesti ripetuti ogni giorno, gli errori che si trasformano in stile. Le persone non cercano aziende perfette e immacolate come nelle brochure. Cercano luoghi dove l’imperfezione venga accolta, riconosciuta, trattata con rispetto – non nascosta sotto un tappeto di frasi fatte e stock images con gente che ride senza motivo. Alla fine, il miglior employer branding è quello che sa raccontarsi anche nei momenti “storti”. È l’azienda che riesce a guardarsi allo specchio, magari un po’ appannato, senza dover aprire Photoshop, ma semplicemente soffiando via il vapore con il coraggio di chi sa che ciò che si vede… è davvero sé stessa.


PER LA RUBRICA L’ANGOLO DEL DISAGIO Non abbiamo alternative alla positività. “Il fatto che non mi vedi sorridere mai non significa mica che non sono positivo, anzi” “Non sono negativo, sono realista. Mica come voi che vi fate i castelli in aria” “Si vabbè, fai sempre l’ottimista tu, ma che ne sai… Beata ignoranza, se vivessi anche solo una piccola parte dei miei problemi non faresti così tanti sorrisi”. Sarà forse per il nome di battesimo che mi porto dietro come eredità del mio compianto nonno paterno (Felice), ma questo tema della positività e della felicità mi è sempre stato a cuore. Sorvolando sulle difficoltà adolescenziali affrontate nel gestire quello che più che un nome è un aggettivo indeclinabile tra maschile e femminile (tra bimbi certi vezzi o eccezionalità possono facilmente diventare bersaglio di feroci scherni), sono sempre stato convinto che essere realisti fosse la cosa che contasse di più nella vita e il migliore alleato per affrontare e risolvere qualsiasi problema. Sebbene i realisti non siano certamente persone che vanno in giro con un sorriso a 36 denti stampato sulla faccia. Questa falsa connessione tra felicità e positività va spiegata, perché quando parliamo di positività o di approccio positivo alle sfide e alla vita, non significa certo andare incontro a qualsiasi evento ci accada con una paresi facciale settata su un sorriso smagliante. L’essere umano, come tutte le altre specie presenti sul nostro pianeta, è guidato da un forte senso di conservazione e di preservazione. Non è quindi per sua natura incline al cambiamento e ciò è stato appurato a suo tempo anche da Charles Darwin quando ha postulato che la selezione naturale è il principio per il quale una lieve variazione di un tratto, se utile in natura, è preservata. Pertanto l’uomo non è incline alle variazioni, ma le subisce e come tale, se non è in grado di adattarsi velocemente al cambiamento, diventa materiale defunto di discussione per i posteri. Essere idealisti e sganciati dalla realtà è certamente un modo per cadere nella trappola della selezione naturale, perdersi elementi concreti e fattuali che sono estremamente necessari per compiere proattivamente dei cambiamenti. Lo è però anche il voler a tutti i costi conservare le condizioni all’interno di un mondo costantemente impermanente. Spesso il realismo non è altro che un'espressione molto estrema di una paura ancestrale di ciò che non si conosce. La paura è anch'essa un elemento vitale, è il motore necessario a preservare tutte le conquiste evolutive che la nostra specie ha raggiunto finora. Esiste un precario equilibrio tra la paura e il coraggio di affrontare le necessarie opportunità di cambiamento. E lì si colloca il dibattito tra il pessimista (colui che rigetta ogni opportunità), il realista (che si muove con discrezione, un po' meno immobile del pessimista) e l’ottimista (che invece abbraccia qualunque tipo di cambiamento). Lì si colloca anche il nostro modo di affrontare la vita tutti i giorni. La corsa per la sopravvivenza non è certo una passeggiata di salute domenicale, piuttosto un percorso pieno di ostacoli e di pericoli. Basta vedere qualche documentario che riprende la savana e la vita degli animali allo stato brado per rendersi conto come un nonnulla possa essere fatale; come una distrazione, un passaggio sbagliato o una mossa sfortunata possano mettere fine alla vita di specie forti e potenti. L’attenzione e la paura giocano sicuramente da alleati in questo caso, ma non bastano per aiutarci a sopravvivere. Ci indicano i rischi e i pericoli in agguato ma non ci danno quella forza e quel coraggio necessarie per guardare al di là di ciò che ci circonda. La positività nasce dall’accettazione delle paure come parte integrante del nostro modo di affrontare il mondo e non come un blocco alla nostra vita stessa. Positività significa accettare la variabilità, l’impermanenza e l’evoluzione stessa della Vita come qualcosa di limitatamente controllabile, per focalizzarsi invece su ciò che possiamo controllare e/o modificare di noi ovvero su cosa possiamo imparare da noi stessi. In questo senso essere positivi non significa necessariamente essere “felici”, ma significa rendersi conto delle innumerevoli opportunità che ci circondano e della possibilità, in una grande maggioranza dei casi, di fare leva su risorse a noi più o meno conosciute. Focalizzandoci sulle opportunità piuttosto che sulle paure riusciremo più velocemente e consapevolmente a procacciarci le risorse necessarie e a sviluppare quelle competenze indispensabili per vincere la corsa alla sopravvivenza. Quante volte rimaniamo schiacciati dalle nostre paure quotidiane, quante volte costruiamo pensieri e narrative che accendono le nostre paure e l’istinto di conservazione. Nella stragrande maggioranza dei casi ci stiamo proteggendo però da…noi stessi e perdiamo il focus della crescita e dell’allenamento. Ed è un fatto che al di là del senso di sicurezza che può darci un surrogato piacere istantaneo, alla lunga vedere altri che invece vanno avanti e superano le difficoltà, controbilancia tale piacere con una discreta dose di frustrazione. Pur consapevoli infatti che l’ottimismo e la positività potranno comportare il compimento di qualche errore ogni tanto, il vantaggio che se ne deriva rispetto al semplice e pragmatico realismo è, alla lunga, indiscutibile. Quindi, tanto vale farsene una ragione!


INTERGENERAZIONALITÀ IN AZIENDA: TRA CAFFÈ, RIUNIONI E TEAM BUILDING. Ovvero come far convivere vecchi merletti e nativi digitali. Nel contesto aziendale, ogni giorno si intrecciano esperienze di generazioni che hanno vissuto e interpretato il rapporto di lavoro in modi diversi. Il Baby Boomer ha costruito la sua carriera in un’epoca in cui la fedeltà aziendale era sinonimo di sicurezza e crescita professionale, con un approccio gerarchico e basato sulla seniority. La Gen X ha vissuto la transizione verso un mondo più dinamico, imparando a bilanciare carriera e vita personale in un contesto sempre più competitivo. Gli Xennial, sospesi tra il passato analogico e il futuro digitale, hanno sviluppato un’attitudine camaleontica, adattandosi a nuove tecnologie senza rinunciare a metodi tradizionali. I Millennial, invece, vedono il lavoro come un mezzo per realizzarsi, ponendo il focus sul work-life balance e sulla flessibilità, spesso scontrandosi con strutture aziendali ancora rigide. Infine, la Gen Z porta con sé un approccio altamente digitale e orientato al cambiamento rapido, privilegiando ambienti lavorativi agili e inclusivi. In questo intreccio, la vera sfida sta nel trovare un linguaggio comune che valorizzi le differenze e crei un senso di appartenenza condiviso. Immaginiamoci per un momento, una scena di vita aziendale e di trovarci alla macchinetta del caffè, luogo simbolo dell’interazione intergenerazionale. Qui immaginiamo di incontrare l’ingegner Rossi, 58 anni, veterano dell’azienda con decenni di esperienza alle spalle, e Luca, 27 anni, giovane professionista cresciuto nell’era digitale. Due mondi diversi, due approcci opposti al lavoro, ma uniti dal comune desiderio di un buon caffè. L’ingegner Rossi, con la sua inossidabile tazzina in ceramica, osserva Luca, che con fare distratto mescola la sua bevanda in un bicchierino compostabile, mentre scorre le notifiche su LinkedIn. "Ai miei tempi, il capo non ti mandava un’email per dirti che c’era una riunione, veniva alla scrivania e te lo diceva di persona!" sbotta Rossi. Luca alza un sopracciglio e replica con un mezzo sorriso: "E ai tuoi tempi c'era ancora il telegrafo, vero?". Risate generali, tensione sciolta. Durante una riunione strategica in cui si devono definire le linee guida per il prossimo trimestre. L’idea di Rossi è di standardizzare i processi per garantire efficienza, mentre Luca e la sua collega Martina, 32 anni, propongono di sperimentare un nuovo approccio agile, con sprint settimanali e feedback continui. "Ci serve stabilità, non rivoluzioni ogni tre mesi!" esclama Rossi. "E se provassimo una fase pilota?" suggerisce Martina, tentando la via della mediazione. Qui entra in gioco il manager, 45enne navigato, che cerca di armonizzare le esigenze: "E se stabilizzassimo il processo, ma lasciassimo spazio a micro-innovazioni controllate?". Accordo trovato, altra scena risolta. La discussione poi si accende quando arriva la proposta di una giornata di team building. Il comitato organizzatore, composto prevalentemente da under 40, propone un'esperienza immersiva in un escape room, seguita da una cena gourmet in un ristorante fusion. Rossi e la sua generazione avrebbero preferito una giornata di soft trekking con degustazione di vini. "Escape room? Ma io voglio rilassarmi, non risolvere enigmi sotto pressione!" protesta il veterano. "Ma dai, è divertente!" ribatte Luca. "Soprattutto quando il tuo gruppo perde e devi offrire da bere...". Si opta infine per una soluzione ibrida: mattina di outdoor experience e serata di networking con un buffet che soddisfi tutti. Questi episodi sono il riflesso di un contesto aziendale dove persone con esperienze e visioni diverse devono trovare un equilibrio. Come in un'orchestra, ogni strumento suona una melodia distinta, ma solo l'armonia tra tutti crea una sinfonia efficace. La sfida dell’intergenerazionalità non è solo una questione di anagrafe, ma di mentalità. Ad esempio, in una recente iniziativa aziendale, un team di giovani ha proposto un sistema di feedback istantaneo tramite app, mentre i colleghi più esperti hanno insistito per mantenere i tradizionali report mensili. Dopo una discussione aperta, si è trovato un compromesso: una sintesi settimanale su piattaforma digitale, che ha migliorato la comunicazione per tutti. L’errore più comune? Sottovalutare l’importanza del dialogo e dell’ascolto reciproco. Un'azienda che sa valorizzare la diversità di esperienze e prospettive diventa più resiliente e innovativa. Ad esempio, aziende come General Electric, IBM e Unilever hanno implementato un programma di mentorship inversa (reverse mentooring), in cui i dipendenti più giovani formano i colleghi senior sulle nuove tecnologie, mentre ricevono in cambio consigli strategici e di leadership. Questo scambio ha portato a un aumento del 20% nella produttività e a un miglioramento del clima aziendale. I Boomer possono insegnare la pazienza, la dedizione e la visione strategica a lungo termine. I Millennial e la Gen Z portano freschezza, velocità e un’inclinazione naturale alla digitalizzazione. La chiave sta nel creare ponti, non muri. A fine giornata, in ascensore, Rossi, Martina e Luca si trovano a condividere gli ultimi istanti prima dell’uscita. "Luca, ma davvero lavori meglio da casa?" chiede Rossi con sincera curiosità. "Sì, ma non sempre. Mi piace il mix: focus da remoto, brainstorming in ufficio. Così evitiamo riunioni inutili e abbiamo più tempo per il lavoro vero". Rossi annuisce, mentre l’ascensore si ferma al piano terra. "Forse un giorno ci proverò anch’io", mormora con un sorriso. L’azienda, come la vita, prospera quando le generazioni si ascoltano e collaborano, trovando un equilibrio tra tradizione e innovazione. La consapevolezza di appartenere a una comunità in cui ogni esperienza ha valore rende il cambiamento non solo necessario, ma anche un'opportunità di crescita per tutti.
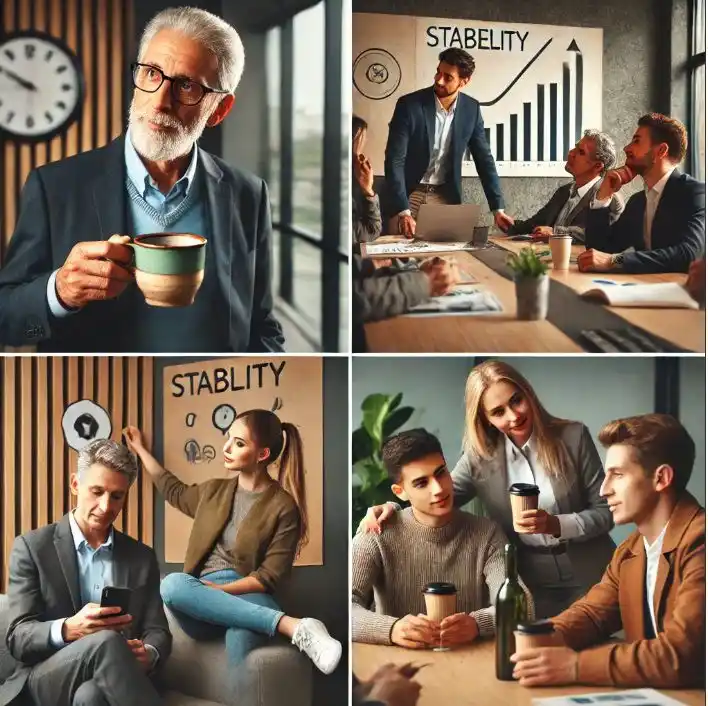

DELLA FEDELTÀ E DELLA COMPETENZA. “Quanto è importante circondarsi di ‘yes man’?” “Boh, non so, l’unica cosa che so è che ogni anno se ne sfornano sempre di più…e sono praticamente tutti nella nostra azienda!” “Dobbiamo decidere velocemente e non possiamo permetterci di non avere l’organizzazione a bordo, è importante fare un’opera di grande persuasione e chi non è d’accordo, beh quella è la porta!” Quando mi capita di dibattere su questo tema ammetto che il rischio che possa correre un (estremo) iperattivo come me, sia quello di mischiare tanti temi e soprattutto per partire per mille autostrade differenti salvo poi ritrovarmi nel bel mezzo del nulla e nella nebbia. Il dilemma tra fedeltà e competenza è un dilemma da sempre presente nelle società moderne e occidentali, sicuramente da dopo il periodo illuminista con lo sdoganamento della conoscenza anche alle classi sociali meno agiate e che non hanno avuto, per secoli, accesso ai temi della conoscenza. La competenza è stata certamente il motore del progresso e della sopravvivenza del genere umano rispetto alle altre specie animali planetarie, la capacità scientifica ha aiutato l’essere umano a guadagnare terreno vincente nella competizione naturale, a velocizzare lo scambio di informazioni attraverso la tecnologia della parola, a procacciarsi cibo per sé e per le future generazioni, a superare malattie e barriere di salute che hanno permesso di prolungare produttività e longevità. Viene da dire che la capacità dell’uomo di imparare e conoscere sia stata la sua vera arma, l’alleato principe che ha permesso di continuare a primeggiare. Attraverso lo studio e l’analisi attenta dei comportamenti sociali dell’essere umano, abbiamo però imparato anche che l’essere umano è considerato quello che si definisce un “animale sociale”, ovvero un essere che entrato in età adulta, vive organizzandosi, dapprima in branchi, poi in tribù e successivamente in società strutturate, cosiddette civili. Alla base di questo aggregarsi sta la relazione sociale, che nella nostra specie è rappresentata da un misto di emozioni e razionalità. Gli esseri umani socializzano, condividono, fanno squadra, si alleano, si misurano, celebrano, si combattono, conquistano, creano vite e le uccidono. La dinamica relazionale, all’interno della società umana, gioca un ruolo fondante. Non esiste tecnologia che generi frutti in senso assoluto ma essa può generare valore solo attraverso le maglie della relazione e della connessione umana. E, come abbiamo visto, la connessione umana è fortemente legata alle emozioni. La fiducia è una di queste. Quando in aula con i miei discenti tocchiamo il tema della fiducia, spesso mi capita di indicare come la fiducia non possa fondarsi a priori se non su basi razionali e formali (“mi fido di ciò che mi viene detto”) salvo poi verificarla e viverla e contestualmente valutare in quale modo e quanto farla evolvere. Bene. Ma su quali basi evolve e si muove la fiducia? Ed è su questa domanda che – finalmente – voglio condividere con voi il mio pensiero. Attraverso un esempio. Supponiamo di fare un giro in macchina con uno sconosciuto. Entrambi abbiamo la patente e una volta davanti all’auto decidiamo che sia lo sconosciuto mr. X a guidare. Ha la patente, quindi in partenza tendo a applicare un minimo di fiducia (basato sulla formalità e sulla razionalità). Una volta in moto potrò misurare – escludiamo per un momento i discorsi su percezione e realtà – la sua qualità di “autista” attraverso la competenza. Se la valuterò negativamente, di conseguenza la fiducia verrà a scemare. Se valuterò la sua come una guida buona allora la mia fiducia aumenterà. E magari la volta successiva mi farò scarrozzare in giro ancora senza paura. Come vedete, in una situazione normale, un elemento chiave come la fiducia – e di conseguenza la fedeltà – si misurano attraverso la competenza. Se invece avessi basato la fiducia solamente conoscenza personale dell’individuo e magari su emozioni o sensazioni provate in passato, avrei dovuto andare a cercare sensazioni provate con altri sconosciuti – con facili scivolamenti in bias e stereotipi, oppure avrei dovuto desistere dal farmi portare in giro. Una fiducia e quindi una fedeltà che si muove esclusivamente su parametri emotivi, è una fiducia che non fa crescere la relazione e non la fa evolvere. Quindi dovremmo affermare che la competenza guida la relazione verso porti di maggior valore. E invece… e invece cosa succede quando non ho gli strumenti per valutare la guida dell’altra persona (magari non ho mai preso la patente o non ho mai guidato) o calibro la competenza sulla base di parametri sbagliati o troppo emotivi? Finisce che cado in balia di preconcetti o valutazioni poco veritiere. Ma soprattutto finisce che sono guidato solo da “incalibrabili” aspetti emotivi, come la paura, il senso di incapacità e inadeguatezza, il senso di potere o interesse o banalmente l’incapacità di valutare appieno le conseguenze di determinate decisioni, sia prese da me che dalla persona che ho a fianco. Quando ci si trova davanti ad un ostacolo, se si possiedono le competenze base per superarlo, allora saremo in grado di pesare e soppesare tutte le variabili in gioco, sia quelle che riteniamo abilitanti, sia quelle bloccanti. Se, per contro, non possedessimo queste competenze, finiremmo a non sapere che passi fare e a non comprendere i rischi e i pericoli che ci troviamo ad affrontare, riportando il tutto su un piano emotivo e costruendo la fiducia – spesso con chi poi deve aiutarci – solo sulla base di ciò che rassicura i nostri bisogni. Una fedeltà che si costruisce sull’incompetenza non genera necessariamente degli yes man, ma delle persone che non sanno più leggere e interpretare i segnali di pericolo se non come degli attacchi alla persona e quindi delle inutili resistenze. Il tema quindi non è se sia giusto o meno circondarsi di competenti e tecnici o di yes man, ma di essere capaci di discernere di cosa si ha bisogno e come poterlo ottenere, con capacità ma anche con giudizio emotivo.














